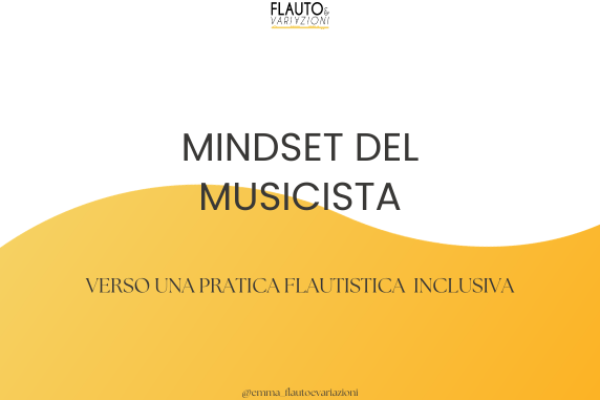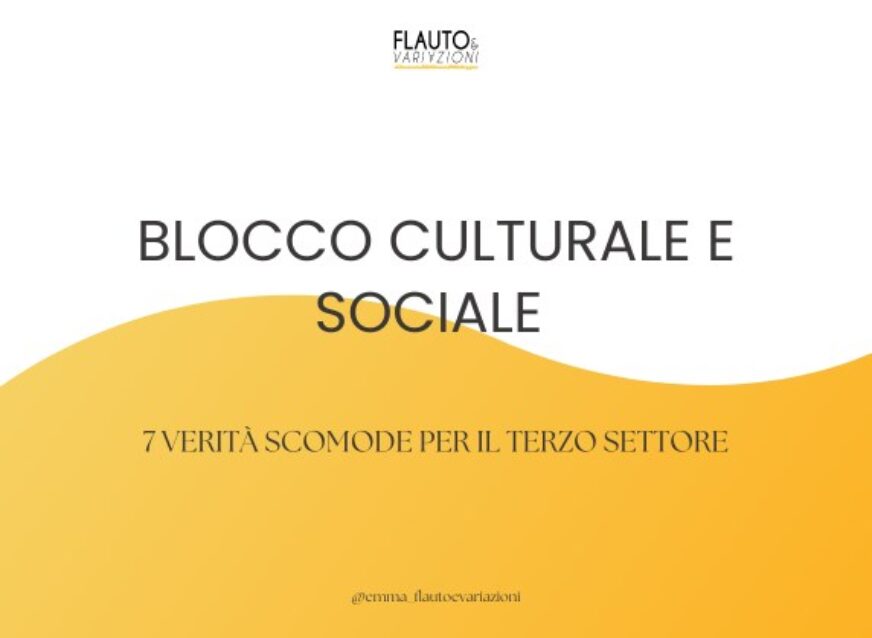
Blocco culturale e sociale: 7 verità scomode per il Terzo Settore
Il paradosso invisibile del blocco culturale e sociale
Le parole “cura”, “cultura” e “aiuto” sono celebrate nei discorsi ufficiali, ma purtroppo sono alle stesso tempo svalutate nei fatti. Chi lavora per il benessere collettivo spesso si scontra con mancanza di riconoscimento, precarietà, e stereotipi culturali. Perché chi si dedica al prossimo, alla salute mentale, al supporto educativo o alla crescita personale, come counselor, coach, terapeuti, formatori, insegnanti, continua a essere visto come un volontario, un “idealista”, o peggio, un lavoratore marginale? Perché la cultura è considerata un lusso e non una necessità? Questo è il cuore del blocco culturale e sociale, un ostacolo invisibile ma potente che minaccia la trasformazione del terzo settore.
In questo articolo analizziamo 7 verità scomode ma illuminanti che spiegano come la cultura, spesso trascurata, sia in realtà la chiave per sbloccare il potenziale nascosto del terzo settore. Perché la cultura non solo ci definisce, ma ci condiziona, e come possiamo trasformarla in leva per il cambiamento.
Cosa si intende per Blocco culturale e sociale?
7 verità scomode per il Terzo Settore
1. La cultura è ovunque… eppure nessuno sa definirla bene
La cultura non è solo arte, musica o letteratura. È l’insieme di valori, credenze, pratiche, linguaggi, rituali e simboli che una società condivide. È ciò che ci fa sentire parte di un gruppo, che orienta le nostre scelte, che definisce cosa è “normale” e cosa no. È nei media che consumiamo, nelle religioni che pratichiamo, nei codici di abbigliamento, nelle mode, nei detti popolari, nelle opinioni comuni.
Eppure, quando chiediamo “cos’è la cultura?”, pochi sanno rispondere con chiarezza. Questo perché la cultura è così pervasiva da diventare invisibile. Ma invisibile non significa innocua: è proprio questo suo essere “data per scontata” che la rende così potente.
2. La cultura è una rappresentazione collettiva che plasma la società
Ogni società ha bisogno di raccontarsi. Senza una narrazione comune, senza simboli condivisi, non può esistere coesione sociale. La cultura soddisfa questo bisogno profondo: ci dà un’immagine di chi siamo, a cosa apparteniamo, cosa possiamo aspettarci dalla vita.
Queste rappresentazioni non sono astratte. Sono create da persone vere che lavorano, amano, soffrono, fanno festa, proprio come i membri di un clan aborigeno o una comunità urbana contemporanea. Attraverso arte, media, religione, moda, si cristallizzano le esperienze collettive.
È grazie alla cultura che i gruppi sociali si identificano e si distinguono, e attraverso essa si costruiscono confini, norme, simboli di appartenenza. Questo vale anche per le professioni del terzo settore, che però spesso non hanno ancora una rappresentazione culturale forte e condivisa.
3. Cultura e società sono dinamiche, ma non sempre sincronizzate
La cultura cambia, ma non sempre allo stesso ritmo della società. Esistono momenti di stabilità, in cui le idee sono condivise e le regole sembrano fisse. Ma ci sono anche momenti di crisi e rivoluzione, in cui le vecchie convenzioni crollano, lasciando spazio al nuovo.
Un esempio eclatante è quello degli anni ’60: un periodo di instabilità che ha generato una vera esplosione culturale. Le convenzioni vennero sfidate in ogni ambito: l’arte, la musica, le relazioni di genere, la politica. Dalla Pop Art ai Black Panthers, dal rock psichedelico al femminismo, si crearono nuove narrazioni che ridefinirono la normalità.
E proprio nei momenti di “vuoto morale”, come direbbe Durkheim, l’innovazione culturale diventa un bisogno collettivo. L’anomia si combatte creando nuovi significati.
4. Non tutte le innovazioni culturali riescono a consolidarsi
L’innovazione culturale può nascere ovunque, ma solo alcune si istituzionalizzano, cioè diventano parte del pensiero comune. Questo accade quando:
-
il contesto storico è favorevole
-
l’innovazione risponde a un bisogno collettivo
-
l’idea è facilmente comunicabile e ripetibile
Gli artisti, ad esempio, si dividono in quattro categorie: i professionisti integrati, che seguono le convenzioni del proprio ambito; gli individualisti ribelli, che le sfidano dall’interno; gli artisti folk, che rappresentano la cultura popolare; e gli artisti naïf, completamente scollegati da qualsiasi sistema culturale.
Curiosamente, solo gli artisti naïf sono veramente innovativi, ma proprio per questo sono spesso ignorati. Le loro opere mancano di reti sociali, pubblico, diffusione. Anche nel terzo settore accade qualcosa di simile: idee rivoluzionarie nascono ma non si affermano per mancanza di struttura culturale attorno ad esse.
5. Il blocco culturale è la principale barriera al riconoscimento del terzo settore
La frase “con la cultura non si mangia” è il simbolo perfetto di questo blocco. Denota una visione riduttiva della cultura come attività accessoria, non produttiva. Eppure, la cultura genera PIL, lavoro, coesione sociale. È fondamentale per la salute mentale, la prevenzione, l’integrazione.
Nel terzo settore, questa svalutazione si traduce in precarietà, scarsa legittimazione e poca visibilità. Le attività di cura sono viste come “naturali” o “volontarie”, non come competenze professionali complesse. È un blocco che limita la crescita, soffoca l’innovazione e impedisce agli operatori di assumere pienamente il loro ruolo trasformativo.
6. Il business coaching può diventare leva per la trasformazione culturale
Nel terzo settore, il business coaching non può limitarsi a insegnare strategie di marketing o gestione del tempo. Deve diventare uno strumento di consapevolezza culturale, aiutando i professionisti a:
-
ridefinire la propria identità
-
riconoscere i condizionamenti culturali
-
sviluppare narrazioni potenzianti
-
uscire dal modello del “lavoro missionario”
Un coach culturale aiuta a rompere gli schemi mentali, a creare linguaggi nuovi, a validare professionalmente ruoli spesso svalutati. Questo è fondamentale per sviluppare un nuovo ecosistema nel terzo settore, in cui la cultura sia considerata una leva di cambiamento strutturale.
7. Per cambiare davvero, serve investire nella cultura come bene primario
La cultura non è un lusso. È infrastruttura invisibile su cui poggiano economia, giustizia sociale, salute mentale, sostenibilità. Superare il blocco culturale e sociale significa:
-
investire in educazione culturale
-
sostenere l’arte e il pensiero critico
-
favorire il dialogo tra settori
-
costruire narrazioni nuove per professioni vecchie
Ogni professionista della cura, ogni operatore sociale, ogni educatore ha un ruolo da svolgere in questo cambiamento. Ma servono strumenti, formazione e spazi in cui la cultura non sia solo contemplata, ma vissuta e trasformata.
Oltre il blocco, verso una nuova consapevolezza collettiva
Il blocco culturale e sociale è come una nebbia che offusca il potenziale della società. Ma, come ogni costruzione umana, può essere smontato. Serve una rivoluzione silenziosa ma radicale, che parta dalla consapevolezza, dall’educazione, dalla formazione. Diamo valore alla cultura, non solo come eredità, ma come leva strategica per reinventare il presente. Perché se è vero che “con la cultura non si mangia”, allora è anche vero che senza cultura, non si vive davvero.
Nel terzo settore, questa trasformazione è urgente e necessaria, ecco perché il mio lavoro su flautoevariazioni.com, rappresenta proprio questo ponte tra cultura e cambiamento sociale.
Se vuoi approfondire questi temi, iscriviti alla mia newsletter settimanale!